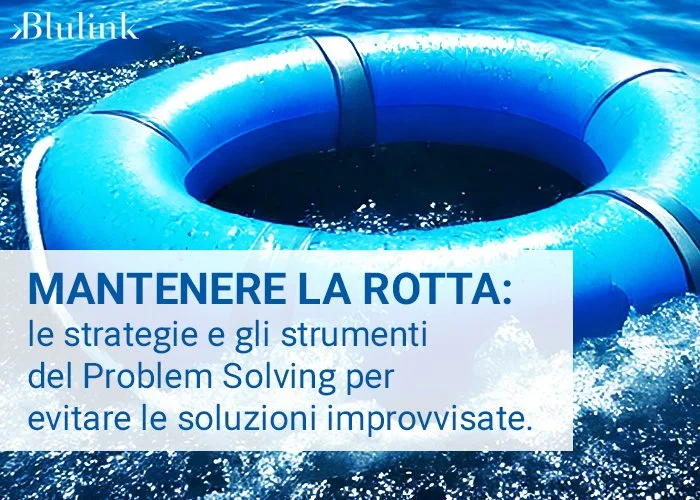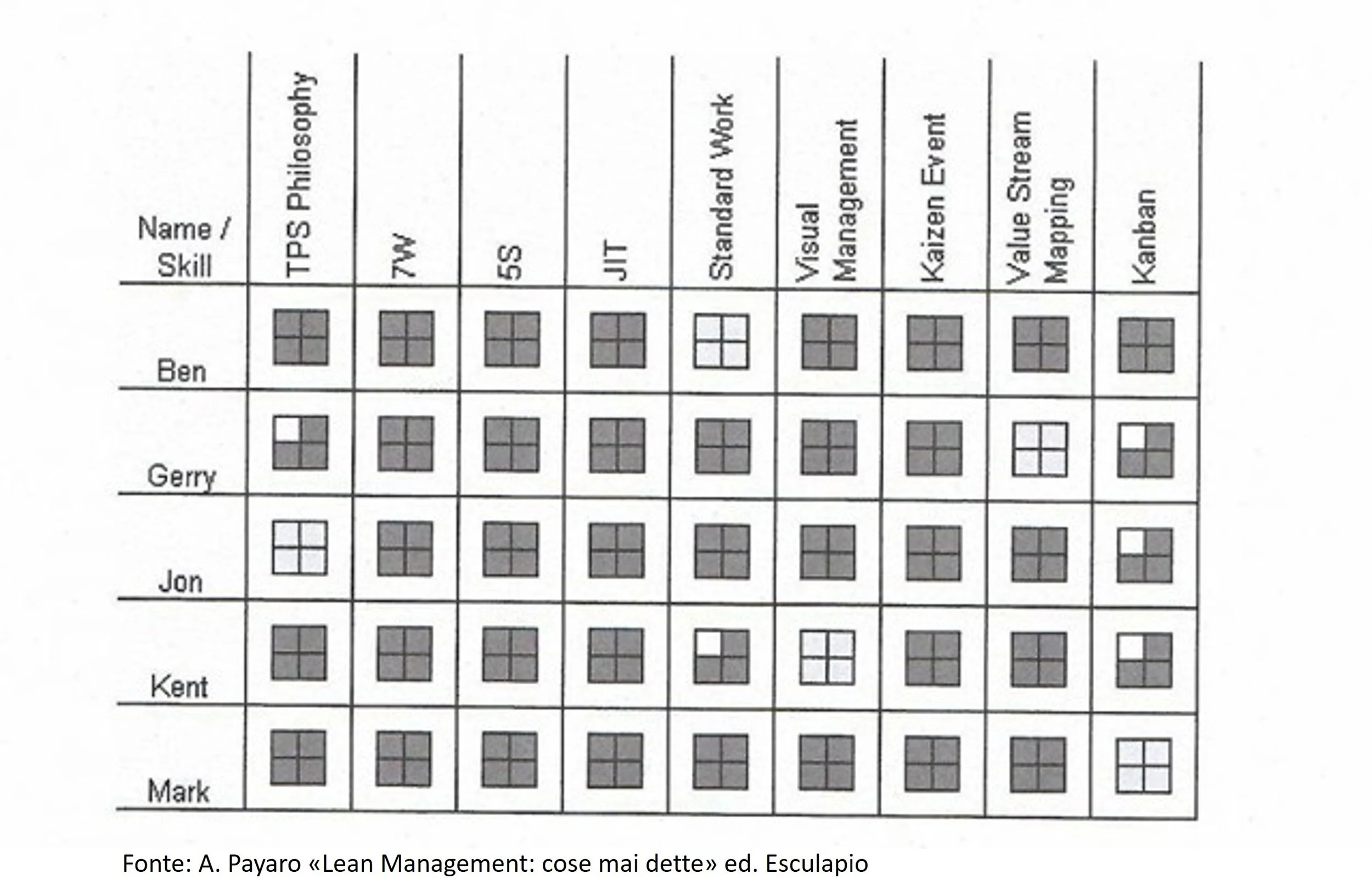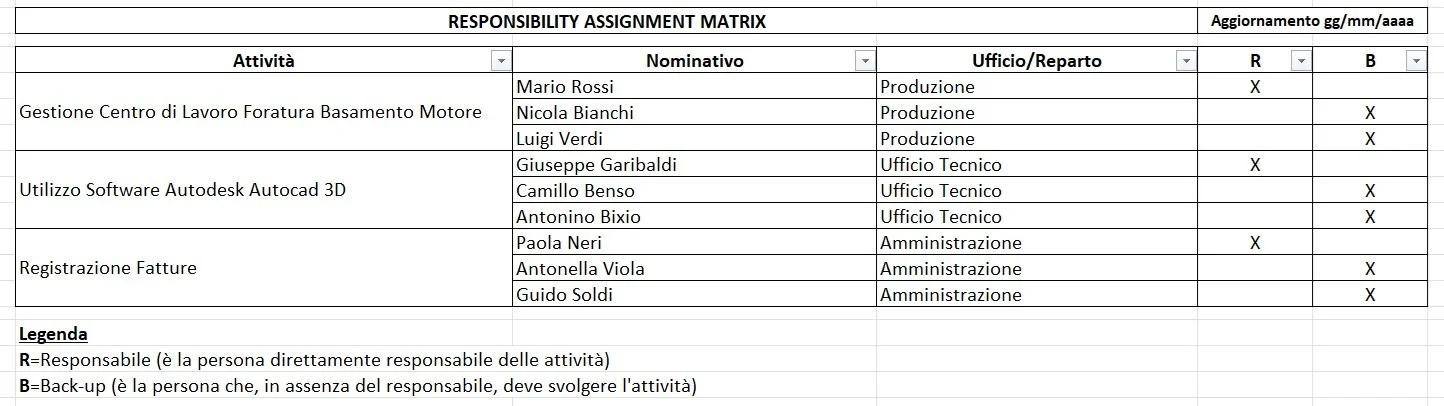Raccontiamo la storia e l’organizzazione di TATA, una realtà familiare che, nata nel lontano 1868, rappresenta oggi un conglomerato industriale il cui fatturato supera i 100 miliardi di dollari e che ha tra i propri slogan “Improving the quality of life of the communities we serve” e “Leadership with trust”.
Le origini e lo sviluppo del Gruppo Tata
Jamsetji Tata (foto dal sito)
Nel 1868, in piena epoca coloniale britannica, Jamsetji Nusserwanji Tata fonda a Bombay un’impresa che, inizialmente, opera nel settore tessile e che avrebbe lasciato un segno profondo nel panorama industriale dell’India.
Visionario e innovatore, il capostipite della dinastia industriale Tata era animato dalla profonda convinzione che la vera forza dell’industria risiedesse nella sua capacità di migliorare la vita delle persone.
Negli anni nascono così, tra le varie iniziative, Tata Steel, la prima acciaieria integrata dell’India, ma anche una centrale idroelettrica, un hotel di lusso – il Taj Mahal Palace Hotel a Mumbai – e l’Indian Institute of Science, università tecnico-scientifica creata da Jamsetji Tata investendo il proprio patrimonio personale con la ferma convinzione dell’importanza della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore nei processi di trasformazione e di crescita sociale ed economica.
In tutti questi progetti si evidenziava un chiaro modello di sviluppo: un’industria guidata non solo dal profitto, ma da un fine più alto. In questo approccio ritroviamo la via che Adriano Olivetti ha cercato di applicare anche in Italia, purtroppo con diversa fortuna.
Tata Steel, ad esempio, fu pioniere nell’ambito del welfare aziendale: fin dal 1910 introdusse un orario di lavoro di 8 ore, assistenza medica, scuole, ferie pagate, fondo pensione, formazione professionale, bonus, congedo maternità, molto prima che fossero pratiche comuni nelle aziende.
Intorno all’acciaieria, Tata ha creato anche un esempio di urbanizzazione, la città di Jamshedpur, con strade ampie, alberi, aree verdi, strutture sportive e luoghi di culto religiosi per vari gruppi comunitari. Per realizzare il progetto sono stati coinvolti architetti come Frederick Charles Temple e Otto Koenigsberger, che applicarono il modello della “garden city”, pianificazione urbanistica in cui i quartieri e gli isolati sono circondati da "cinture verdi".
Fondata nel 1945 come TELCO (Tata Engineering and Locomotive Co. Ltd.), Tata Motors rappresenta il cuore industriale e simbolico delle trasformazioni del gruppo. Iniziò costruendo locomotive, ma già nel 1954, grazie a una joint venture con Daimler-Benz, entrò nel settore dei veicoli commerciali, procedendo per passi successivi alla diversificazione della produzione e alla creazione di una propria autonomia tecnologica.
Negli anni ’80, sotto la spinta di Ratan Tata, l’azienda iniziò a orientarsi al settore delle autovetture.
La Tata Indica, lanciata nel 1998, fu la prima vettura interamente progettata e prodotta in India destinata anche ai mercati internazionali.
Seguirono diverse acquisizioni strategiche: nel 2004 la sudcoreana Daewoo Commercial Vehicle, nel 2008 le prestigiose Jaguar e Land Rover.
A partire dal 2010, Tata Motors ha intrapreso un nuovo ciclo trasformativo, questa volta orientato a design, sicurezza e sostenibilità ambientale. Tata Motors oggi ha un proprio portafoglio di tecnologie ed è tra i leader in diversi settori, rappresentando un caso esemplare di trasformazione continua, in risposta alle sollecitazioni del mercato, ambientali e tecnologiche.
J.R.D. Tata (foto dal sito)
Altro esempio degno di essere citato è anche quello di Air India, fondata da J.R.D. Tata nel 1932 come Tata Airlines che, dopo la nazionalizzazione degli anni '50, nel 2022 è stata riacquisita da Tata Sons che ha intrapreso un importante piano di rilancio per portare il vettore a essere una compagnia aerea globale di livello mondiale con un cuore indiano.
La filantropia come struttura portante:
il ruolo delle Tata Trusts
Un aspetto peculiare del Gruppo Tata è che circa il 66% delle azioni di Tata Sons, la holding del gruppo, è controllato dalle Tata Trusts, istituzioni filantropiche che operano fin dai primi anni di vita delle industrie Tata. Questo assetto garantisce che la strategia industriale del gruppo sia guidata da un interesse collettivo, e non solo da quello privato.
Le Tata Trusts promuovono iniziative per l'istruzione, la salute, la cultura e i mezzi di sussistenza in India (foto dal sito)
Le Tata Trusts gestiscono un patrimonio superiore a 11 miliardi di dollari e donano oltre 400 milioni l’anno per progetti in sanità, educazione, ambiente, empowerment rurale e innovazione sociale. Ad esempio, durante la pandemia hanno stanziato oltre 180 milioni di dollari per strutture sanitarie, vaccini e dispositivi medici.
In campo educativo, promuovono iniziative come Internet Saathi (un programma di alfabetizzazione digitale che coinvolge oltre 1 milione di donne in aree rurali attraverso un modello "train-the-trainer", in cui le donne formate, le "Internet Saathis" insegnano ad altre donne della loro comunità a utilizzare Internet e i dispositivi digitali) e sostengono università e scuole d’eccellenza, come il già citato Indian Institute of Science. Nella sanità vengono finanziati ospedali oncologici e programmi di screening su larga scala. Nel settore ambientale, realizzano attraverso Tata Power campagne di sensibilizzazione energetica, riforestazione e risparmio idrico.
Infine, attraverso piattaforme come Tata Engage, oltre un milione di ore di volontariato vengono donate ogni anno da dipendenti, pensionati e familiari, creando una vera “cultura civica aziendale”.
Le Tata Trusts sono oggi guidate da Noel N. Tata, nominano circa un terzo del board di Tata Sons e godono di diritto di veto strategico. Ciò assicura un controllo etico sulla visione di lungo periodo, pur lasciando autonomia operativa al management.
Questo equilibrio tra famiglia, manager professionisti e filantropia rappresenta senza dubbio un unicum nel panorama industriale internazionale.
Conclusione: una lezione per il XXI secolo
La storia del Gruppo Tata è la dimostrazione concreta che l’impresa familiare può essere globale, etica e innovativa allo stesso tempo. In 150 anni, il gruppo ha attraversato imperi, crisi, liberalizzazioni e rivoluzioni tecnologiche senza perdere di vista la propria identità.
Grazie a una leadership stabile ma aperta al cambiamento, a un sistema di controllo fondato su Trusts filantropici, e a una costante capacità di anticipare e guidare le trasformazioni industriali, Tata è oggi un faro di capitalismo responsabile.
Nel tempo della transizione ecologica, delle disuguaglianze crescenti e dell’intelligenza artificiale, il Gruppo Tata ci ricorda che la trasformazione d’impresa non è solo questione di strategia, ma anche di scopo, comunità e coraggio etico.
Andrea Calisti
Business Transformation Expert
Nella foto di copertina: Tata Sons Private Limited, la principale holding del gruppo Tata
BLUPEAK - Business is culture