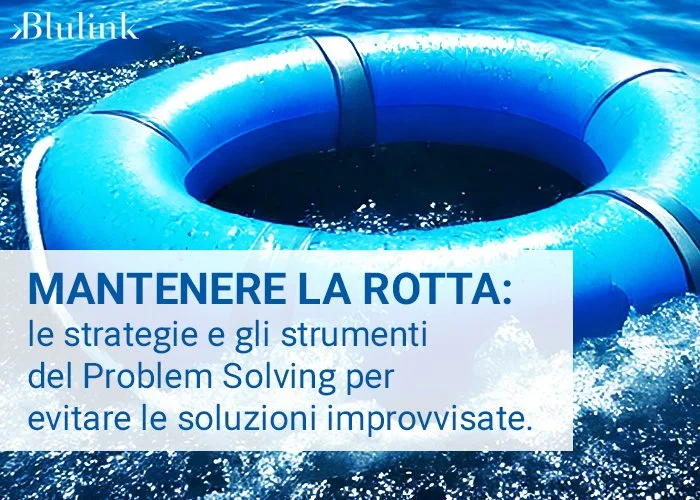“La domenica fiorentina si presentava finalmente serena dopo il nubifragio del giorno prima. Una pioggia sferzante che aveva costretto, il pomeriggio di sabato 3 ottobre 1964, le auto con a bordo il presidente del Consiglio, Aldo Moro, e l’amministratore delegato della società Autostrade, Fedele Cova, a procedere a passo d’uomo da Orvieto a Chiusi. Era l’ultimo tratto che mancava per rendere l’A1 – esattamente sessant’anni fa – l’autostrada che conosciamo: la dorsale d’asfalto, allora avveniristica, che univa per la prima volta le macroaree del Nord, del Centro e del Sud.” (Corriere della Sera, 3 ottobre 2024, a cura di Daniele Piazza)
Oggi un’opera simile, da 60 anni motore di sviluppo economico e di incontro tra le diverse aree d’Italia, costata in valuta attuale circa 3,5 miliardi di euro, sarebbe probabilmente realizzata in Project Financing.
Vediamo quindi di approfondire questa modalità di operare.
Un concept tutto italiano
L’idea di un’arteria stradale esclusivamente dedicata al traffico automobilistico, contrariamente a quanto si possa credere, non nasce con l’Autostrada del Sole e non proviene dall’estero.
Fonte: Wikipedia
La prima autostrada al mondo nasce tra il 1924 e il 1925 per collegare Milano ai laghi lombardi e permettere le prime gite turistiche in automobile (che all’epoca, essendo un privilegio per pochi, si prendeva a noleggio completa di chauffeur).
Fonte: Corriere della Sera
Passano circa 30 anni e il 19 maggio 1956, a San Donato Milanese (altro luogo reso celebre come culla del progresso industriale grazie all’ENI di Enrico Mattei), viene celebrata la posa della prima pietra della futura A1 alla presenza dell’allora presidente della Repubblica Giovanni Gronchi e dell’arcivescovo di Milano Giovan Battista Montini, futuro papa Paolo VI.
Dal 1956 al 1964, in soli 8 anni, vennero realizzati 755 chilometri di nastro d’asfalto per collegare Milano a Napoli con 113 ponti e viadotti, 572 cavalcavia, 38 gallerie, 57 raccordi, 56 aree di servizio.
L’idea di questa infrastruttura vede la luce tra il ‘53 e il ‘55 ad opera della SISI (Società Iniziative Strade Italiane, il consorzio aziendale composto da Fiat, Pirelli, Agip e Italcementi), che sviluppa il progetto di massima dell'autostrada con le sue tappe principali (Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli), ipotizzandone già il sostegno finanziario tramite la riscossione dei pedaggi. Nel 1955 la SISI trasferisce il progetto allo Stato. Si crea così una “congiuntura perfetta” di comunità d’intenti tra Governo, competenze tecniche e capacità delle maestranze, che ha permesso di realizzare un investimento di 272 miliardi di lire (pari ad attuali 3 miliardi e mezzo di euro circa).
Se oggi si dovesse realizzare un’opera simile, con un impegno economico corrispondente a quello citato, molto probabilmente si ricorrerebbe a una soluzione di Project Financing.
Il Project Financing: mezzo per lo sviluppo infrastrutturale (da utilizzare con attenzione
Il Project Financing è una metodologia di finanziamento a lungo termine impiegata in particolare per la realizzazione di progetti che comportano un rilevante impegno finanziario, come quelli relativi alle infrastrutture.
La caratteristica peculiare del Project Financing è che il rimborso del debito contratto per finanziare il progetto si basa esclusivamente sui flussi di cassa generati dall’infrastruttura oggetto del progetto (esempio un’autostrada, ma anche un tratto ferroviario, un aeroporto, un’infrastruttura energetica), anziché sulla solvibilità finanziaria dei soggetti promotori. Il progetto stesso rappresenta quindi la garanzia esclusiva per il finanziamento della realizzazione, in grado di ripagare il debito e di generare rendimenti per gli investitori.
I principali attori coinvolti nel Project Financing sono gli sponsor, gli istituti finanziari, le autorità pubbliche e le società fornitrici.
Gli sponsor sono di solito aziende o consorzi che si occupano della concezione, dello sviluppo e della gestione del progetto.
Le banche o i fondi d’investimento rivestono il ruolo di finanziatori, valutando la sostenibilità economica del progetto e definendo le modalità di erogazione del prestito (che spesso copre la maggior parte del fabbisogno finanziario).
Le autorità pubbliche sono coinvolte nell’assicurare il corretto, ma celere, sviluppo dell’iter burocratico collegato al progetto, così come nell’offrire incentivi fiscali, concessioni, garanzie o contributi a fondo perduto per favorire la realizzazione di opere che rispondano a esigenze collettive, come infrastrutture sanitarie, stradali o scolastiche.
Per lo sviluppo del progetto, in caso di esito positivo dell’analisi di fattibilità su rischi, costi e benefici, viene creato appositamente uno “Special Purpose Vehicle” (SPV), ovvero una società che ha lo scopo di gestire l'iniziativa e di detenere il debito e gli attivi del progetto. La SPV agisce come veicolo legale e rappresenta l’entità giuridica responsabile di tutti i contratti e gli obblighi legati al progetto. Tale aspetto è importante poiché protegge gli sponsor dai rischi.
Lo SPV raccoglie il capitale necessario, realizza il progetto e gestisce l’infrastruttura o l’impianto, generando i flussi di cassa necessari a ripagare il debito. Il progetto deve quindi dimostrare di essere autosufficiente e capace di generare reddito nel lungo termine.
Il Project Financing ha diversi vantaggi:
permette la realizzazione di opere complesse senza gravare sui bilanci aziendali degli sponsor o sulla spesa pubblica;
facilita l’attrazione di capitali privati anche per progetti pubblici, favorendo la collaborazione tra pubblico e privato.
Tuttavia, il Project Financing presenta anche delle problematiche che devono essere prese in esame con attenzione:
il processo è complesso e richiede studi di fattibilità dettagliati e una rigorosa gestione dei contratti;
i costi di transazione, consulenza e monitoraggio possono essere elevati, e i tempi di negoziazione con le banche o i fondi sono spesso lunghi.
se il progetto non genera i flussi di cassa previsti, possono sorgere difficoltà nel rimborso del debito, esponendo gli investitori a perdite.
Quattroruote sul tracciato della BreBeMi (A35) rispetto alla A4
Un esempio relativo all’ultimo rischio citato è sicuramente quello dell’autostrada A35 (la cosiddetta BreBeMi): i bassi flussi di traffico dovuti al costo dei pedaggi, nonostante la minore lunghezza del percorso rispetto all’alternativa rappresentata dall’utilizzo della preesistente A4, mettono a rischio la redditività del progetto.
CONCLUSIONI
Il Project Financing rappresenta sicuramente uno strumento strategico per finanziare progetti di grande rilevanza, i cui rischi devono tuttavia essere tenuti nella giusta considerazione dai Project Manager chiamati a gestire questo tipo di iniziative.
Le modalità operative permettono di attrarre risorse private in settori dove la spesa pubblica non è sufficiente o dove si punta a ridurre il debito pubblico; tuttavia, lo studio preliminare di fattibilità e l’analisi dei rischi devono essere condotti con particolare attenzione, soprattutto in proiezione lungo il ciclo di vita del progetto, per valutarne correttamente la redditività rispetto agli investimenti da rimborsare.
Con l’aumento delle esigenze infrastrutturali e lo sviluppo di tecnologie verdi, il Project Financing è probabilmente destinato a crescere, diventando sempre più un pilastro per il finanziamento di progetti innovativi e sostenibili. Questa situazione genererà la necessità di avere figure professionali correttamente formate non solo nella gestione di questi progetti, ma anche, come detto, nello sviluppo degli studi di fattibilità e delle analisi di rischio preliminari.
Andrea Calisti
Business Transformation Expert
BLUPEAK - Business is culture