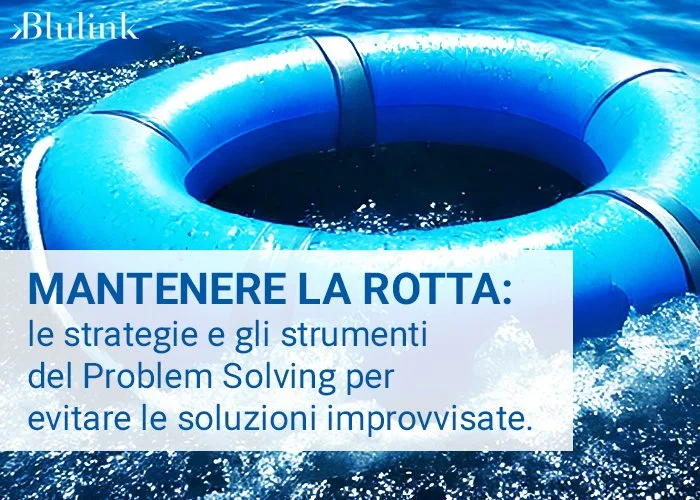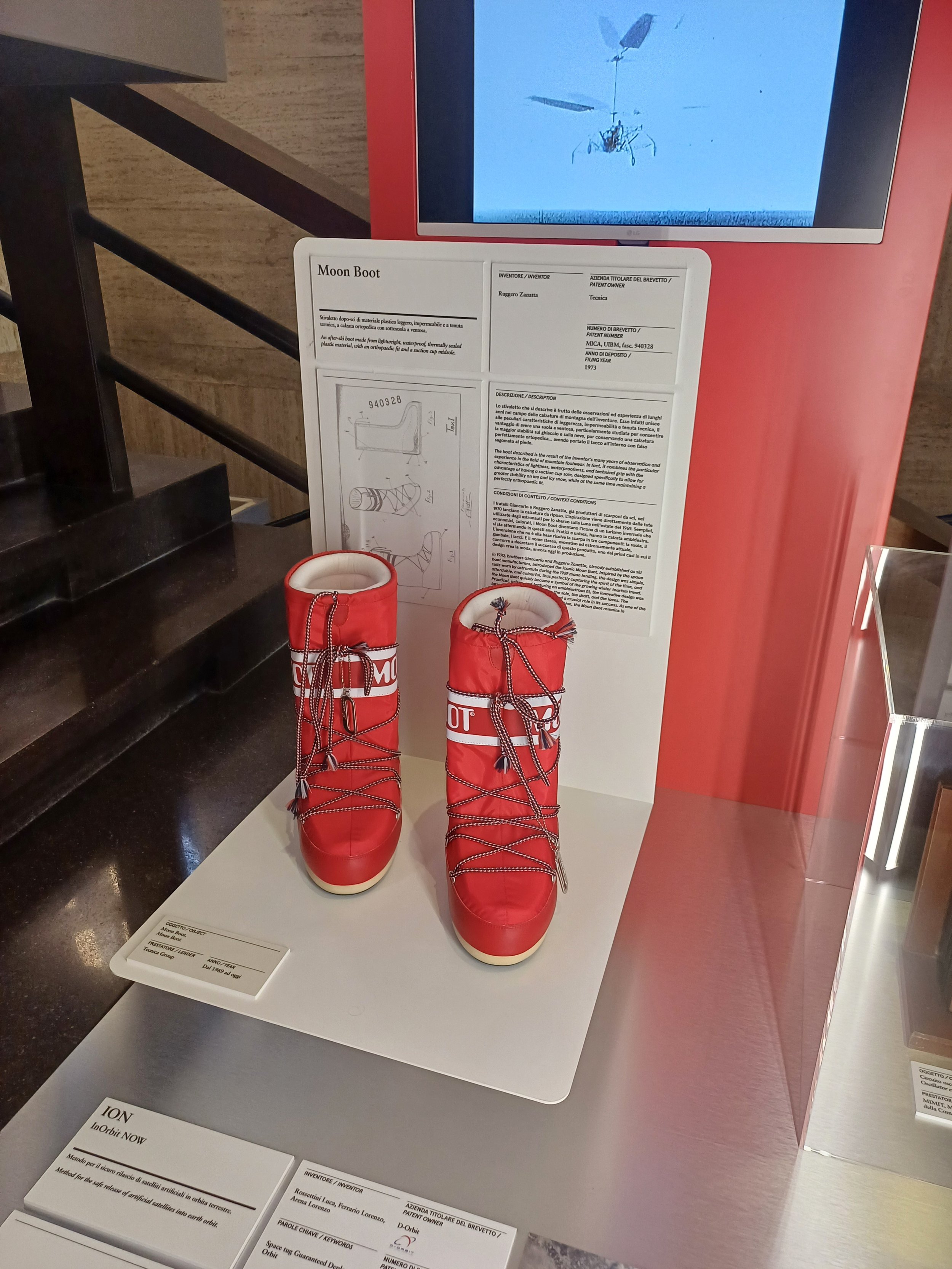In un mondo in cui la tecnologia, i mercati e le regole del gioco cambiano velocemente, le imprese che intendono restare competitive devono sviluppare programmi di Ricerca & Sviluppo sia “in house” che aprendosi all’esterno. L’Open Innovation, incoraggiando la collaborazione sui flussi di idee, tecnologie e competenze, è determinante per ridurre tempi e costi d’innovazione, scalare nuove soluzioni e costruire ecosistemi capaci di generare valore condiviso.
Open Innovation: cos’è
Per Open Innovation si intende un insieme di pratiche che permettono a un’impresa di combinare risorse interne ed esterne per creare, sviluppare e portare sul mercato nuove idee. Le modalità operative possono esplicarsi secondo diverse modalità: acquisizione di idee/tecnologie esterne, valorizzazione di asset tramite licenze o spin-off, co-sviluppo e partnership “end-to-end”.
A questo approccio corrispondono una serie di strumenti operativi, quali acceleratori, corporate venture capital (CVC), hackathon, challenge, partnership università-impresa, piattaforme di matching e procurement di startup (venture client).
Foto di Satheesh Sankaran - Pixabay
Ricadute dell’Open Innovation
e situazione del sistema industriale italiano
L’Open Innovation ha diversi effetti positivi:
accelera il time-to-market grazie all’integrazione di idee già validate esternamente;
riduce il rischio e i costi di R&D condividendo investimenti e sfruttando competenze esterne;
amplia il portafoglio di competenze (es.: A.I., materiali avanzati, digital manufacturing, energie rinnovabili, ecc.) più velocemente di quanto sia possibile internamente;
favorisce la creazione di ecosistemi che moltiplicano le opportunità di business e le sinergie tra attori.
Questi vantaggi non sono tuttavia automatici, ma emergono quando l’Open Innovation è governata in modo strategico, con strutture interne dedicate, processi di selezione e integrazione e metriche chiare.
Negli ultimi anni il mercato italiano dell’Open Innovation ha mostrato segnali di crescita strutturale, non senza però alcune fragilità:
un’analisi del mercato segnala che il valore complessivo dei servizi di Open Innovation in Italia ha raggiunto livelli significativi con stime attorno a 742 milioni di euro (2023);
l’ecosistema degli incubatori e acceleratori è ampio e in evoluzione: in base a una recente analisi (2024-2025) si contano centinaia di incubatori/acceleratori in Italia (con variazioni e consolidamento), mentre il numero di startup innovative registrate è sceso leggermente nel 2024 (circa 15,9 mila), indicando che il mercato è in una fase “selezione”;
il quadro europeo colloca l’Italia nella categoria di “Moderate Innovator”: performance in crescita (nel 2024 + 15 punti rispetto al 2017) ma ancora sotto la media dell’UE. I punti di forza includono pubblicazioni congiunte pubblico-private, produttività delle risorse, adozione dell’innovazione di prodotto e di processo anche da parte delle PMI.
Questo quadro mostra due aspetti: da un lato, esiste un mercato e una domanda di servizi di Open Innovation vivace e in evoluzione, dall’altro l’ecosistema italiano sta attraversando una fase di selezione e maturazione che richiede scelte calcolate da parte delle imprese.
Le grandi aziende, d’altra parte, adottano approcci diversificati rispetto al tema dell’Open Innovation e della sua attuazione: dall’accelerazione sistematica, agli hub territoriali per specifiche tematiche (es. la transizione energetica), fino all’adozione operativo-industriale e alla sperimentazione in fabbrica. Queste metodologie complementari possono essere replicate anche nelle PMI con il giusto mix di strumenti.
Le sfide specifiche per l’Italia e per le PMI
L’esperienza italiana evidenzia alcune difficoltà ricorrenti:
Dimensione media delle imprese: molte PMI hanno risorse limitate per presidiare progetti di O.I. Sono necessari modelli “leggeri” che non richiedano grandi strutture interne.
Capacità di assorbimento: è necessario investire in competenze interne (technology scouting, open innovation manager, unità R&I, Academy aziendali per garantire e sviluppare la conoscenza) al fine di non perdere il valore apportato dalle collaborazioni esterne.
Mercato di capitale di rischio e CVC: il Corporate Venture Capital in Italia è in crescita, ma ancora limitato rispetto ad altri paesi. Tale aspetto influenza la capacità delle grandi imprese di investire in modo strutturato nelle startup.
Governance della proprietà intellettuale e modelli contrattuali: occorre sviluppare pratiche standard e modelli contrattuali che possano facilitare l’ingresso e l’uscita dai progetti, nonché la condivisione dei benefici senza eccessiva complessità legale, favorendo la trasparenza e riducendo i rischi di compromessi.
Per trasformare il business sfruttando l’Open Innovation, le aziende possono seguire diverse linee operative:
segmentare gli obiettivi di O.I.: definire chiaramente in quali ambiti (es. sostenibilità, digitale, produzione, post-vendita, ecc.) ricercare innovazione esterna;
adottare modelli di ingresso proporzionati: soluzioni specifiche alle dimensioni e alla capacità/propensione all’investimento;
contribuire agli ecosistemi locali: costruire collaborazioni con poli universitari, centri di ricerca e incubatori per facilitare scouting e sperimentazione;
investire in capacità di assorbimento dell’innovazione: formazione, team misti R&D-business, ruoli dedicati allo scouting e all’integrazione;
misurare l’innovazione: creare e monitorare KPI che misurino velocità di integrazione, valore commerciale generato, percentuale di innovazione proveniente da partner esterni e tasso di successo delle “proof of concept” (dimostratori di idee);
standardizzare contratti e protezione IP: adottare modelli e pratiche contrattuali snelle che accelerino la collaborazione senza aumentare i rischi legali;
prestare attenzione alle politiche incentivanti: utilizzare, anche con supporti esterni, gli strumenti che vengono messi a disposizione a livello nazionale e regionale per sostenere l’innovazione di prodotto e processo.
Foto di andreas_baetz - Pixabay
Conclusione
L’Open Innovation è un potente moltiplicatore di valore per le imprese. Permette di accelerare i cambiamenti, ridurre rischi, accedere a competenze avanzate e costruire ecosistemi resilienti agli scenari di mercato. Tuttavia, non si tratta di una bacchetta magica, ma richiede strategia, investimenti in capacità interne, governance chiara e strumenti contrattuali adeguati. Casi reali mostrano che l’Italia ha le basi per scalare questa pratica migliorando ulteriormente i propri indicatori a livello europeo, ma occorre un impegno comune per rendere l’Open Innovation una pratica diffusa, sostenibile e misurabile, in grado di creare valore in modo capillare dalle grandi aziende alle Piccole e Medie Imprese.
Andrea Calisti
Business Transformation Expert
BLUPEAK - Business is culture