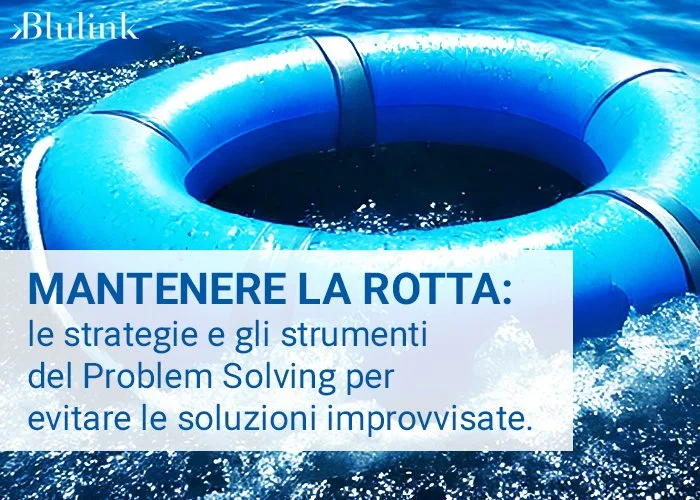Proseguendo con l’articolo, affrontiamo ora nello specifico l’argomento academy, fino a parlare di un effetto collaterale importante delle azioni di formazione, per giungere infine alle conclusioni.
Accademie e Centri di Formazione
Rispetto a questi problemi le aziende hanno escogitato, codificato e condiviso, nel corso di anni di attività, molteplici procedure, metodi e buone pratiche. Le iniziative di creazione di accademie[1] aziendali sono nate per trasformare gli aspetti problematici che abbiamo esposto in opportunità per l’accrescimento del valore proposto sul mercato di riferimento, e per generare un adeguato profitto.
Vogliamo, nel prosieguo di queste note, esporre alcune considerazioni sull’istituzione delle Accademie aziendali, prendendo spunto da alcuni esempi illustri.
La Gelato University di Carpigiani Gelato University è nata nel 2003 e si è affermata come la più importante scuola di gelateria del mondo. Fino a quel momento la Carpigiani era nota come fabbrica di macchine per la realizzazione di gelati, che commercializzava con successo in tutto il mondo. Una macchina può essere copiata e riprodotta, i brevetti possono essere rispettati, ma le idee circolano e il rischio di perdere importanti quote di mercato era concreto. L’idea che ha portato alla realizzazione della Gelato University era semplice: attirare persone da tutto il mondo a imparare come si realizza questo prodotto nel paese che l’ha inventato. Anziché cedere conoscenze di rilievo, con i modi che abbiamo descritto, diventare un punto di riferimento costante per chi, dall’artigiano al dipartimento dell’industria dolciaria, voglia eccellere e mantenersi al livello dello stato dell’arte.
La Gelato University è un esempio eccellente, ma solo per rimanere nel territorio emiliano sussistono altri esempi di valore quali Cremonini, Tetrapak, Coop, IMA. Le aziende della Motorvalley, inoltre, hanno avviato collaborazioni con le principali università e scuole di business del territorio. La lista degli esempi virtuosi potrebbe continuare.
Accademia come programma aziendale
La creazione di un’accademia non si limita a impostare l’infrastruttura, i sistemi di regole, i ruoli e i contenuti sufficienti ad avviare un’azione di formazione e che possono essere oggetto di un progetto specifico. L’obiettivo, infatti, è di portare la soluzione a essere efficace e di mantenere tale efficacia nel tempo, e richiede un approccio per programmi[2] e un’azione di cambiamento organizzativo e culturale che abbraccia l’intera organizzazione che la istituisce.
La caratteristica di un programma è la creazione di un beneficio, che ha una relazione diretta con gli obiettivi strategici dell’organizzazione[3]. Il programma è composto da componenti gestiti in modo coordinato per creare e mantenere nel tempo i benefici, i quali, dopo essere stati creati, vengono trasferiti a qualche entità che ne fruisce e vengono mantenuti con opportune azioni di sostegno.
Nel caso della creazione di un’accademia aziendale, il beneficio da generare può essere, ad esempio, ridurre del 90% la dispersione di informazione o dell’80% le perdite economiche che da essa derivano; inoltre, come scrivevamo poco sopra, la creazione di infrastrutture e contenuti non è sufficiente per garantire un successo di lungo periodo: i contenuti debbono essere adattati alle esigenze degli stakeholder e aggiornati allo stato dell’arte; ruoli e procedure, così come materiali didattici e strumenti di supporto alla didattica debbono essere aggiornati a loro volta allo stato della tecnologia. È quindi necessario ricorrere a un programma che attinge in modo sistematico a tutte le fonti di informazione di cui l’organizzazione dispone e che ne coordina la sintesi.
L’effetto “Oracolo di Delfi”
Prima di concludere è doveroso citare un effetto collaterale importante delle azioni di formazione.
Nell’antichità, era costume rivolgersi a un oracolo prima di avviare un’impresa. Nel mondo greco ci si recava a Delfi, nella Focide, alle pendici del Monte Parnaso e, dopo essersi sottoposti a un rito di purificazione, si esponeva il proprio quesito all’oracolo, che rispondeva attraverso le parole sibilline della sacerdotessa come ad esempio fece Temistocle, l’ammiraglio ateniese che annientò la flotta persiana nello stretto di Salamina[4].
Quando ricevevano una richiesta, i responsabili del tempio la annotavano e in questo modo, e anche se la consultazione aveva qualche carattere di riservatezza, ricevevano notizie su tutti gli aspetti che ora definiremmo militari, sociali, politici ed economici dell’area del mondo greco, ma anche di alcune delle regioni circostanti, da cui traevano conclusioni che facevano esporre dalla Pizia – la sacerdotessa che secondo la credenza locale aveva il dono della veggenza – con un responso espresso in versi sibillini[5].
Il punto da osservare è che i sacerdoti di Delfi a ogni richiesta di responso acquisivano dati e informazioni che permettevano loro di tenere aggiornata una mappa degli equilibri geopolitici dell’intera area del mediterraneo, rendendo il santuario una specie di banca dati ante litteram.
Chiunque svolga attività di formazione ha sperimentato in senso positivo l’effetto dell’Oracolo di Delfi: il docente attraverso le domande degli studenti apprende, vede la sua stessa materia dal punto di vista dell’allievo e ciò gli permette di generare nuova conoscenza o, se si preferisce, una conoscenza più consapevole. Se questo percorso di raffronto e crescita non si limita all’esperienza del singolo docente ma viene condiviso in modo strutturato, entra a far parte della cultura e crea un circolo virtuoso in cui la formazione – in aggiunta ad altri strumenti predisposti allo scopo – permette di recepire umori e necessità di mercato che possono essere trasferiti sia alle funzioni tecniche e di marketing, per il miglioramento di prodotti e servizi, sia all’alta dirigenza per verificare l’efficacia della strategia.
Conclusioni
La conoscenza che le organizzazioni producono con lo svolgimento delle loro attività costituisce una parte importante del loro valore. La perdita di conoscenze è un problema[6] noto a cui le aziende e gli studiosi hanno dato differenti soluzioni.
L’istituzione di accademie e centri di formazione interni sono uno strumento di uso crescente, sia per garantire conoscenze omogenee e l’istituzione di una comune cultura, ma anche come veicolo di raccolta di spunti e richieste di miglioramento di prodotti e servizi, di conoscenza delle richieste del mercato e di innovazione di prodotto.
Un’accademia aziendale si istituisce mediante un percorso di medio periodo, con un approccio di programma allineato alla visione strategica dell’organizzazione.
[1] Academia era il giardino in cui Platone riuniva i discepoli della sua scuola filosofica e dove scrisse i suoi Dialoghi.
[2] Sulla gestione dei programmi si veda anche “Program Management” di Michel Thiry (Thiry, 2015) in particolare per la relazione fra programmi e progetti e per la nascita dell’approccio per programmi dall’ambiguità delle circostanze in cui le organizzazioni intraprendono iniziative complesse.
[3] Sulla gestione dei benefici si veda anche “Benefits Realization Management” di Carlos Serra (Serra, 2019).
[4] Si veda Erodoto Libro VII delle Storie (Erodoto).
[5] Il responso era volutamente ambiguo e spettava al destinatario la sua corretta interpretazione: si veda ad esempio la sorte di Creso che fraintese il significato della risposta del dio e perse il suo regno (Erodoto, Libro I Ibidem).
[6] Si veda a questo proposito il resoconto sulla conoscenza e la produttività a cura di Panopto (Panopto, 2023) citato in bibliografia.
Bibliografia
Costa, L. (2024, September). Cultural Apects of Lessons Learned. Project Management World Journal.
Dimitrov, K. (2013). Edgar Schein’s Model of Organizational Culture Levels as a Hologram. Economic Studies (Ikonomicheski Izsledvania).
Erodoto. (1996). Le Storie. Torino: Utet.
Grant, R. M. (2021). Contemporary Strategy Analysis. John Wiley & Sons Inc.
Nonaka, I. (2007, July-August). The Knowledge Creating Company. Harvard Business Review.
Panopto. (2023). Workplace Knowledge and Productivity Report.
Schein, E., & Schein, P. (2017). Organizational Culture and Leadership (V ed.). Hoboken: John Wiley & Sons Inc.
Serra, C. E. (2019). Benefits Realization Management. Boca Raton: CRC Press.
Thiry, M. (2015). Program Management. Farnham (UK): Gower.
Luca Costa
Business Transformation Expert
Foto: Cipro - Sito Archeologico di Kourion (Credit: L. Costa)
BLUPEAK - Business is culture